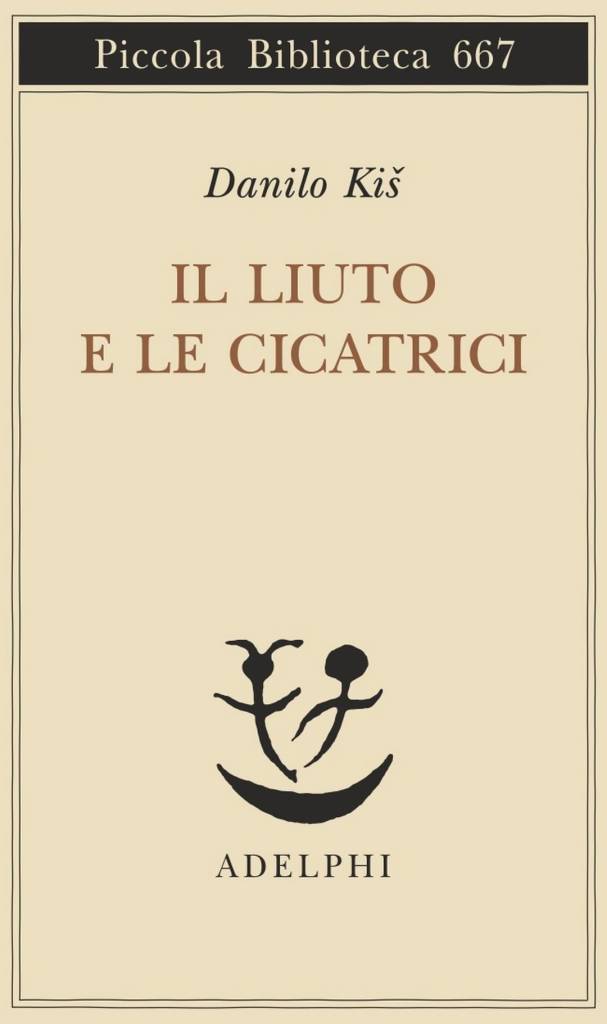La scoperta di Danilo Kiš è stata per me come quando i vichinghi sbarcarono in America. Un intero continente vergine mi si spalancò davanti. Con una differenza. Che fui subito cosciente dell’immensità e della portata di quella scoperta. E dell’immensa epifania intellettuale che sarebbe scaturita dall’esplorazione di quel continente letterario. Finché oggi, con la pubblicazione de “Il liuto e le cicatrici”, la mappa bibliografica di quei luoghi si arricchisce di nuove terre inesplorate. Siamo nel Far West, per rimanere nella metafora. Ma forse non ancora in vista dell’altro oceano. Molto probabilmente l’esplorazione del continente Kiš ci riserverà altre scoperte.
La bibliografia di Kiš comprende molte opere non ancora tradotte in Italia. In una nota al primo racconto di questa nuova raccolta, Mirjana Miočinović, ex moglie dell’autore e curatrice di questa edizione, informa che alcune pagine del “Senza Patria” (il racconto in questione) sono la sintesi di alcuni passaggi dell’“Escursione a Parigi”, racconto di Kiš del 1959, che uscirà prossimamente per i tipi di Adelphi in un volume di saggi e articoli dello scrittore serbo. Ma altri indizi lasciano ben sperare riguardo a prossime pubblicazioni. Ad esempio “Il liuto e le cicatrici” è uscito nel 2012 in edizione inglese, tradotto da John K. Cox. E nello stesso anno, sempre tradotti da Cox, sempre per Dalkey Archive Press, sono usciti “Psalm 44”, romanzo scritto da Kiš a soli venticinque anni e “The Attic”, primo romanzo dello scrittore.
Ma da anni, fin dalle prime opere tradotte, Kiš è diventato uno scrittore di culto. La sua poetica ruota attorno alla figura del padre, che nelle sue opere viene mitizzato. Così come avviene nei due romanzi di Bruno Schulz, dal quale sicuramente Kiš ha tratto ispirazione. Il padre biologico di Kiš e quello letterario dei protagonisti dei suoi romanzi subiscono la medesima sorte. In “Giardino, cenere”, romanzo nel quale, come in “Dolori precoci”, l’autore descrive in una prosa lirica la propria infanzia, il padre predice: «Non è possibile, giovanotto mio, e questo ricordatelo sempre, non è possibile recitare la parte della vittima per tutta la vita senza diventarlo alla fine davvero». E la finzione narrativa s’incaricherà più avanti di avverare questa profezia, così come la storia del ventesimo secolo aveva visto morire il padre di Kiš in un campo di concentramento nazista.
Questo è anche il nucleo narrativo di “Clessidra”. Romanzo moderno e sperimentale, audace e complesso, in cui Kiš abbandona il lirismo dei primi romanzi, per riportarci con la freddezza di un verbale di polizia militare, la tragica realtà della vita nei campi di concentramento. Infine di Kiš conosciamo quello che è forse il suo capolavoro. “L’enciclopedia dei morti”, che può essere paragonato solo alle altre due perfette raccolte di racconti. “Finzioni” e “Bestiario”. Infatti l’autore serbo condivide con Borges e con Cortázar l’arte del racconto perfetto. Quello al quale non potresti togliere o aggiungere niente, nemmeno una virgola, come la precisa formula alchemica che permette la stasi di un elemento esplosivo.
Ah. C’è dell’altro. Chi ama Danilo Kiš, ha mandato emissari in missione per conto del Dio della Parola scritta a compulsare i cataloghi delle più remote librerie del Regno delle Lettere. Finché uno di loro, messaggero trafelato, non se ne tornò vincitore. Sventolando quel libretto scovato nel bugigattolo delle offerte alla Toletta di Venezia. Così come le puttane di Majakovskij, attraverso gli edifici in fiamme, sventolavano il libro del poeta mostrandolo a Dio a loro discolpa e Dio stesso, potete crederci, ruppe in pianto sopra a quel libriccino! E corse per i cieli con quei fogli rilegati sotto all’ascella, per leggerlo, ansando, ai suoi conoscenti! Era “I leoni meccanici”, edizione Feltrinelli, ora ristampato da Adelphi, con il titolo originale: “Una tomba per Boris Davidović”.
Ma torniamo al libro recensito. “Il liuto e le cicatrici”.
Si tratta di sei narrazioni, pubblicate postume nel 1994, alle quali si aggiunge un breve scritto, “A e B”, considerato l’‘epilogo lirico’ dell’intera opera di Danilo Kiš. Questi racconti, ritrovati tra i manoscritti dell’autore alla sua morte, sono stati scritti tra il 1980 e il 1986, periodo in cui stava lavorando a “L’enciclopedia dei morti”. Non è difficile capire, al di là di tutto, vuoi per la frammentarietà, vuoi per l’ispirazione, perché siano stati esclusi da quella raccolta. Sono comunque dei racconti interessanti, perché il Kiš vi mischia invenzione e autobiografia, vicende immaginarie e fatti storici, introducendo alcuni personaggi realmente esistiti, come Ödön von Horvárth, Endre Ady de Diósad, Ivo Andrić o Piotr Rawicz, che si trasmutano in personaggi letterari.
Eppure, se nel complesso questi racconti non sono all’altezza dei migliori. In alcuni brani, simili a squarci di luce, si viene abbagliati dal talento del grande narratore. Come nel frammento 25 del “Senza patria”, dove viene descritta la morte del personaggio, al secolo il drammaturgo Ödön von Horvárth. Un veggente di Amsterdam gli aveva predetto che un grande avvenimento, a Parigi, avrebbe cambiato radicalmente la sua vita. Infatti il destino si premurò di compiere la profezia e Horvárth, passeggiando spensierato sugli Champs-Élysées, fu ucciso sul colpo dal ramo di un albero, staccatosi durante un improvviso temporale. E la pagina in cui Kiš descrive l’attimo della morte è paragonabile solo a certi passaggi cruciali de “La morte di Ivan Il’ič” di Lev Tolstoj. Quegli attimi fatali, in cui la coscienza è sospesa tra la vita e la morte, sensazioni che solo un grande scrittore può raccontarci a parole.
Questi racconti, come detto, risalgono ai primi anni ’80. Nel 1985 Danilo Kiš scriveva una sorta di ‘testamento poetico’, ora in appendice ai saggi raccolti in “Homo Poeticus”, Adelphi, 2009. Diceva: «La scrittura è vocazione, mutazione dei geni e dei cromosomi; si diventa scrittori come si diventa strangolatori. Scrivo perché non so fare altro; perché di tutto quello che potrei fare è la cosa che faccio meglio, e (I hope) meglio degli altri. La scrittura è vanità. Una vanità che talvolta mi sembra meno inutile di altre forme di esistenza. Scrivo, dunque, perché sono insoddisfatto di me stesso e del mondo. Per esprimere quest’insoddisfazione. Per sopravvivere!».
Così Danilo Kiš è sopravvissuto fino ad oggi e ci racconta e ci racconterà ancora altre storie, da un suo luogo privilegiato ci narra di cosa sia l’eternità. Per la grande forza della parola scritta. In uno di questi racconti accenna infatti al potere demiurgico della parola. Un ratto usato come metafora in un romanzo, si materializza al funerale di uno scrittore. Perché «Questo, pensai, era il ratto della similitudine, che dal suo romanzo era arrivato direttamente al cimitero di Montparnasse. Perché nulla è certo tranne la grande illusione della creazione; non c’è alcuna dispersione di energia; ogni parola scritta è come nella Genesi».
Danilo Kiš
Il liuto e le cicatrici
A cura di Mirjana Miočinović
Traduzione di Dunja Badnjević
Piccola Biblioteca Adelphi
Anno 2014